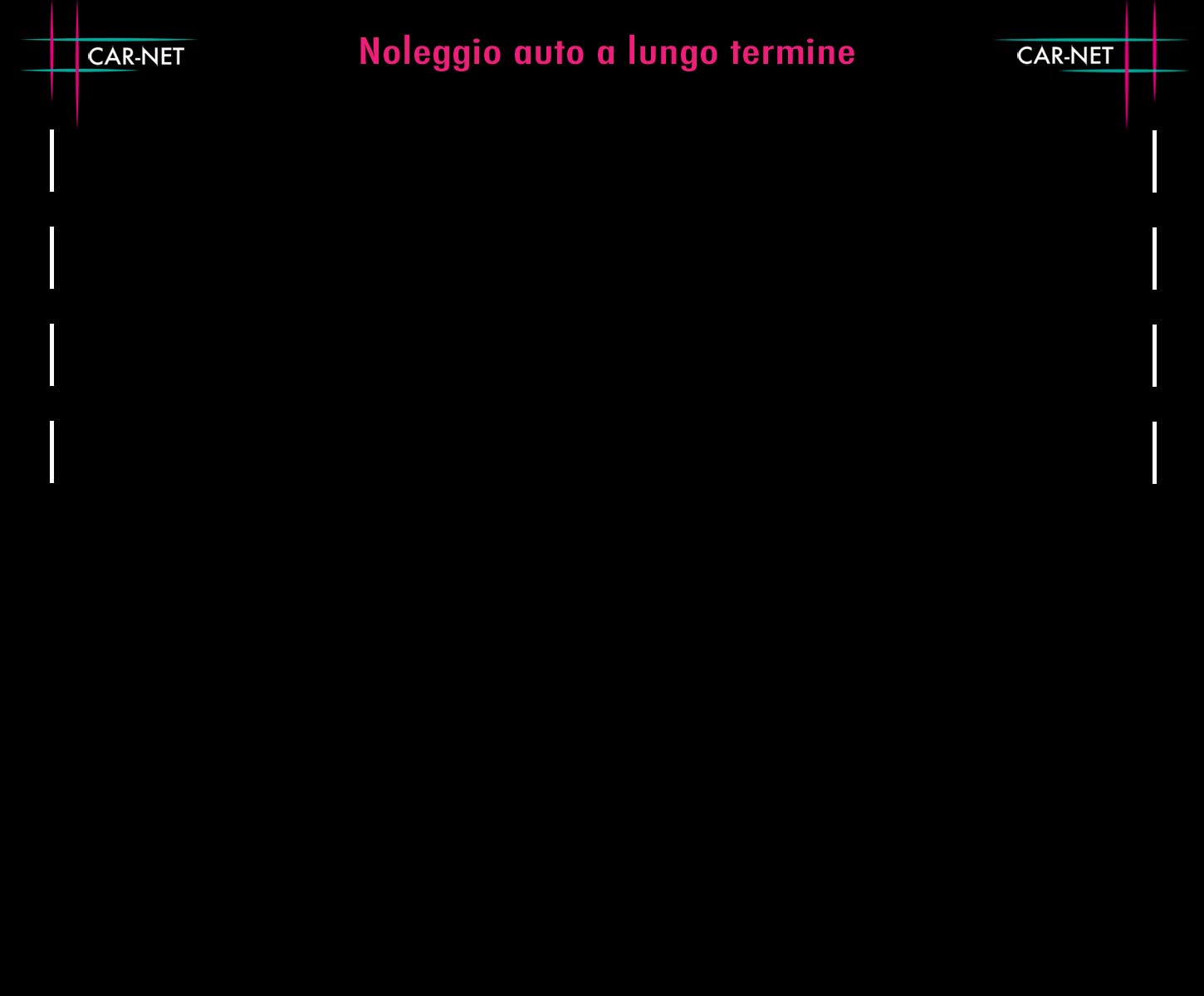Se pensate che parlandoci possa rivelarsi diverso da quello che avete sempre visto in tv, dovete ricredervi: Chef Rubio è esattamente come si presenta sul piccolo schermo. Questo 32enne originario di Frascati e con un passato da rugbista parla in modo autentico e genuino, proprio come la cucina che va a raccontare nel suo programma itinerante “Unti e Bisunti” (DMAX canale 52 dtfree). In onda da settembre con la terza edizione, il suo show televisivo ha avuto il merito di aver dato risalto in Italia al cibo da strada, il cosiddetto street food, mettendo in luce non solo le tradizioni culinarie delle diverse regioni, ma anche chi quelle tradizioni se l’è tramandate di generazione in generazione. Una formula che ha convinto gli spettatori e che ha conquistato anche il pubblico d’oltralpe, tanto che questa nuova edizione vedrà Chef Rubio arrivare fino in Spagna, Germania (Paesi dove i canali Discovery hanno già trasmesso le prime due edizioni) e Francia. Lo abbiamo incontrato e abbiamo parlato con lui di questa nuova stagione, delle esperienze che ha vissuto nel registrarla e del suo “particolare” rapporto con il mezzo televisivo.
Il programma “Unti e Bisunti” è giunto quest’anno alla terza edizione. Ti aspettavi che questo show sarebbe arrivato a questo traguardo?
Quando ho iniziato questa nuova esperienza sinceramente non ho pensato a come potesse evolversi, perché ero molto concentrato a capire come funzionasse questo nuovo lavoro. Non faccio mai il passo più lungo della gamba. Mi concentro molto su quello che devo fare e sapevo che, viste le mie peculiarità e le persone che avevo intorno durante la crescita di questo programma, stavamo lavorando con standard d’eccellenza. Sapevo che stava venendo fuori un bellissimo prodotto. Tutto sta poi nella risposta del pubblico. Finita la prima edizione, e visto che era piaciuta, sarebbe stata una sciocchezza impedire di scoprire alcuni posti (in Italia ma non solo) davvero interessanti, sarebbe stato un suicidio interrompere questo viaggio. “Unti e Bisunti” non esiste solo come modalità di approccio al cibo: sono davvero grato a tutti quelli che ho incontrato, sia alle persone che ci hanno fatto conoscere le loro storie sia ai professionisti che ci hanno permesso di raccontarle.
Nelle nuove puntate stai esplorando lo street food dell’Italia ma, questa volta, ti spingerai anche fino in Germania, Francia e Spagna. In che modo questi tre Paesi propongono e percepiscono il cibo da strada? Quali sono le principali differenze che hai riscontrato rispetto alla stessa esperienza in Italia?
Paese che vai usanza che trovi, no? Nella stessa Italia, ogni luogo diversifica molto la modalità di somministrazione del cibo di strada e la sua tipologia. La Spagna, la Francia e la Germania presentano una situazione totalmente diversa tra loro e totalmente diversa rispetto all’Italia, però di fondo c’è una cosa in comune: la povertà che ha portato determinate persone a ideare e concepire certi piatti, così la storia si ripete. Diverso è l’interprete, diversa è la materia prima, ma il concetto è molto simile.
Un programma come “Unti e Bisunti” ha più lo scopo di rivalutare lo street food o di ridimensionare un po’ l’aura attorno alla cucina dei ristoranti stellati?
Un programma come “Unti e Bisunti” innanzitutto racconta la mia vita, il mio percorso e il mio tentativo di restituirlo al pubblico. Se vado in un posto non è detto che la mia esperienza sia la stessa di quella di qualcun altro nel medesimo luogo. Riporto quello che per strada m’incuriosisce, che voglio conoscere senza domandarmi poi se questo mio gesto può risollevare le sorti di un piatto: sarebbe alquanto presuntuoso. Provo a fare da Virgilio, a capire e quindi raccontare la realtà che vedo, poi sta a chi guarda capire e interpretare il messaggio che c’è dietro. Se poi le persone riportano in auge un piatto ne sono felice, ma io non parto con l’idea di andare in un posto per salvarlo da morte certa. Non c’è nessuna lotta tra me e la cucina stellata.
Anche se sei un sostenitore e un esperto di questo particolare tipo di cucina, hai avuto però una formazione “classica” presso l’Alma di Gualtiero Marchesi. Come concili questi due aspetti apparentemente inconciliabili?
La mia formazione è il mio stesso percorso: parte dal 29 giugno del 1983, quando sono nato. Presso l’Alma ho imparato tantissimo, perfezionando e affinando tutto quello che fino a quel momento avevo incontrato. Sarò sempre entusiasta di quel periodo, però, alla fine, da lì escono 700 cuochi all’anno, ognuno con la propria storia e con il proprio personale percorso da intraprendere. La formazione classica lì è un affinamento: è come se fossi un vino in una botte in rovere, mi sono affinato e, una volta aperto, evoluto.
L’arte culinaria, ormai, è stata declinata in tv in tutte le forme possibili: dal semplice programma che spiega come preparare una ricetta alle sfide in diretta, senza dimenticare ovviamente i numerosi talent. Credi che il pubblico sarà prima o poi stanco di sentir parlare di cucina in tv?
L’argomento cucina è ovunque, non solo in tv, ma in libri, riviste, quotidiani. Per quanto riguarda la televisione, non so dire se questa situazione potrà andare a stancare il pubblico: dipende dall’offerta che viene fatta, dall’interprete. Sicuramente, credo che il cuoco sia un po’ come un becchino: avrà sempre da lavorare. Se si toccano alcune corde, se si propongono dei contenuti veri, credo che la gente avrà comunque voglia di ascoltare. Se si parla della cucina fine a sé stessa allora è diverso: non c’è niente di più tremendamente noioso che parlare di cucina. Se si inseriscono contenuti, racconti, leggende, la cucina diventa una storia che fa parte di noi, che parla di ciò che eravamo e di ciò che un giorno saremo.
Hai dichiarato in passato di non possedere la televisione, non so se adesso è cambiato qualcosa.
No no, continuo a non averla. In realtà non ho neanche una casa… Sono ormai dieci anni che non guardo la televisione, ma mi tengo comunque molto informato attraverso il web e i giornali. In generale la TV non è un mezzo che mi attrae da sempre.
Eppure sei diventato un personaggio televisivo. A cosa è dovuta questa tua scelta?
Non è stata propriamente una scelta mia, ma vostra: mi avete dato credito e sono stato chiamato in causa dalle persone che mi hanno “scoperto”. Io non ambivo ad apparire in tv, però mi hanno chiesto di raccontarmi e così ho fatto. Fino a che poi la gente sarà interessata e mi farà capire che quello che sto facendo è comunque una cosa buona e giusta, allora continuerò a comunicare quello che penso, cosa che faccio comunque a telecamere spente. Diciamo che mi è capitato di finire in tv, però ho saputo fare mia questa opportunità e l’ho portata avanti con serietà perché per me è un lavoro come un altro. Semplicemente c’è una difficoltà maggiore a gestire l’invisibilità, che purtroppo non ho più, ma non fa niente: ci sono tante altre cose belle che mi sono capitate in questo percorso.
Un presente dietro ai fornelli, un passato sul campo da rugby. Ti capita mai di rimpiangere quella vita?
No. Sono riuscito a togliere tutte le soddisfazioni possibili e immaginabili che Gabriele Rubini poteva togliersi con il rugby. Certo, le ambizioni quand’ero piccolo erano altre, ma con il senno di poi ho dato tutto e non ho nessun rimpianto. Quando penso al mio passato ci penso con grande affetto, ma non rimpiango come sono andate le cose.
In un’intervista hai dichiarato che un piatto ha più valore se con esso si racconta una bella storia e si spiega il perché di quel piatto. In che modo Chef Rubio fa comunicazione attraverso la sua cucina?
Credo di farla costantemente attraverso i social: le mie foto su Instagram sono un modo per raccontare i miei viaggi culinari a chi condivide le mie stesse passioni. Negli scatti non mi concentro solo sul piatto, ma anche su chi lo sta preparando e sul paesaggio che ha dato vita a quel piatto, che, slegato dal suo contesto, perderebbe il suo valore. Su Facebook posso invece condividere degli articoli che reputo interessanti, articoli inerenti all’arte culinaria ma non solo. Anche quando magari faccio un piatto per uno specifico evento, non preparo qualcosa di decontestualizzato rispetto all’occasione e al luogo di destinazione. Credo che ogni comunicazione sia ad hoc: se incontro un anziano per strada gli parlo in un modo diverso da quello che uso con un giovane su un social. Non saprei dire però come comunico: lo faccio a modo mio, e non per questo è giusto o sbagliato, ma non saprei fare altrimenti.
Tra le cause che hai appoggiato, c’è anche quella della diffusione e del riconoscimento in Italia della LIS, la lingua dei segni. Hai fatto in passato una video ricetta in LIS e hai anche preso lezioni. Come evolverà questo tuo interesse?
Le lezioni purtroppo le ho dovute interrompere per le riprese del programma, ma spero quanto prima di ricominciare a studiare. L’intento è di fare altre video-ricette in LIS, di dare continuità a questo progetto: non è nella mia natura interrompere così un lavoro del genere. Quanto prima spero di riprendere con questo impegno, che è una delle mie priorità.
Hai detto che la fama televisiva ti ha portato a dire addio all’invisibilità. Questa situazione ti pesa? Ti dà fastidio che tu non possa andare in giro senza essere fermato da chi ti riconosce?
L’invisibilità di cui parlavo si riferisce di più al lato malato del web. L’Italia come patria degli haters non è “male”: dispiace che non ci sia la tranquillità di potersi comportare online normalmente senza avere un occhio di riguardo per eventuali menti “disturbate”.
Per quanto riguarda le persone che mi fermano per strada, che sia per farsi una foto o per chiedere un consiglio, la cosa mi fa molto piacere, altrimenti non farei quello che sto facendo. Le dinamiche che mi danno fastidio sono quelle che nascono quando sei un personaggio pubblico e che portano a “beccarti” in posti in cui non sei mai stato con persone che neanche conosci.
Lucia Mancini